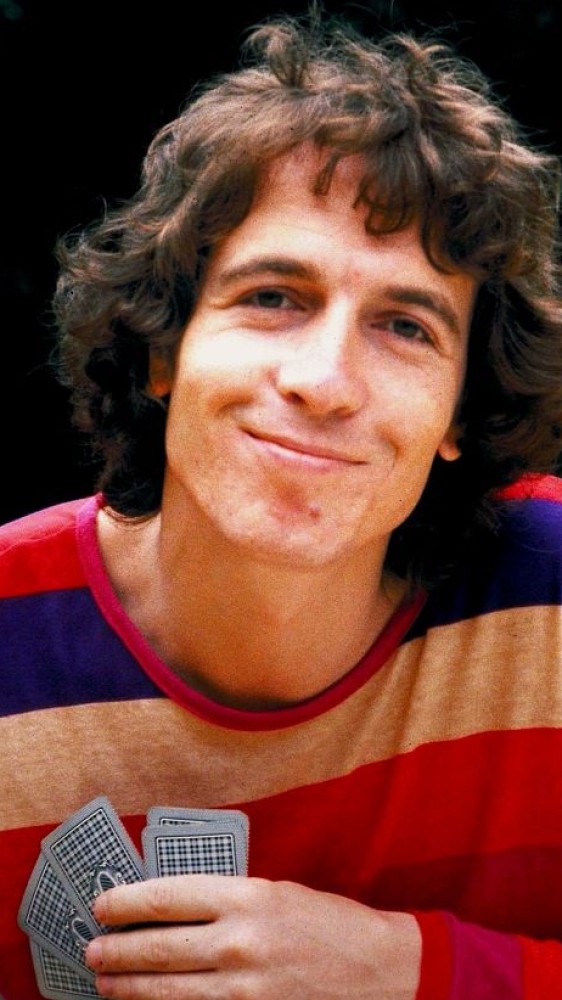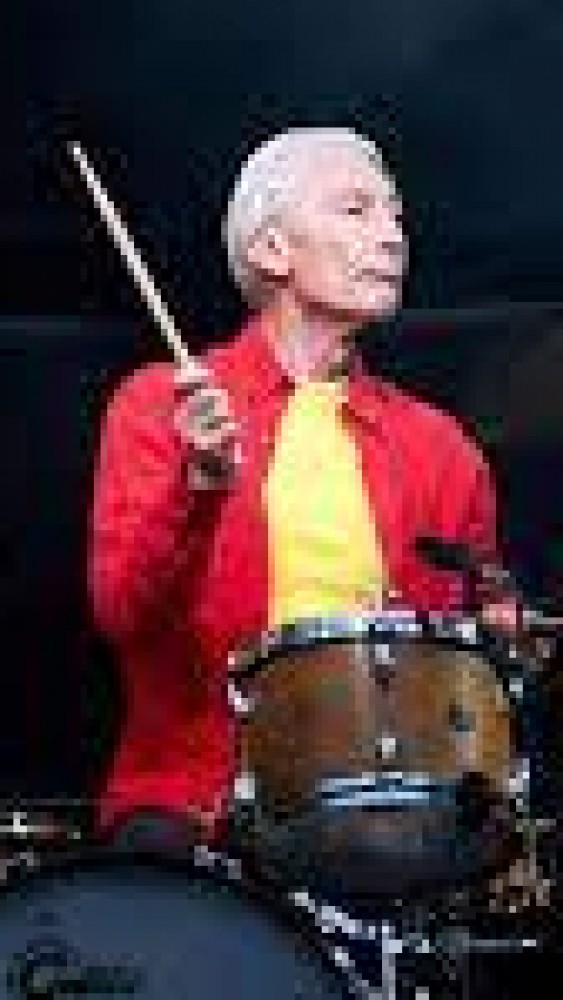Quarant'anni fa la scomparsa di Bob Marley, il leone del reggae e del rastafarianesimo, sopravvissuto a un attentato

Quarant'anni fa la scomparsa di Bob Marley, il leone del reggae e del rastafarianesimo, sopravvissuto a un attentato
11 maggio 2021, ore 12:11 , agg. alle 14:44
L’11 maggio 1981 centomila spettatori rendevano omaggio a Kingston al 36enne mito giamaicano, che aveva sfidato le divisioni nell’isola riunendo sul palco i due leader politici in sanguinosa lotta fra loro. Aveva conquistato anche l’Italia con il concerto di San Siro
Nella bara di bronzo furono poggiati un pallone da calcio, una Bibbia, una piantina di marijuana, la sua chitarra Gibson. Dopo i funerali di stato alla National Arena di Kingston, dove in centomila lo avevano onorato tra canti e balli, Bob Marley fu tumulato sulla collina di Nine Mile, che da baraccopoli divenne un luogo di culto. ll re del reggae se n’era andato l’11 maggio 1981, a soli 36 anni. Soffriva da troppi mesi per un dolore a un piede. Credeva fosse un banale infortunio dopo una delle agguerrite partite di pallone con i suoi Wailers, era invece un melanoma. Per tentare di salvarlo avrebbero dovuto amputargli un alluce, ma lui si rifiutò: nella Bibbia era scritto che i seguaci del rastafarianesimo non potevano farsi tagliare parti del corpo. O tagliare i capelli. Niente lame: solo l’acqua poteva toccare le chiome avvolte in quei riccioli inestricabili, i dreadlock.
Il mito dell’Africa perduta
Bob era un mezzosangue, figlio una giamaicana e di un bianco. Ma la sua anima era protesa verso il Corno d’Africa, la patria perduta degli schiavi portati a soffrire nei Caraibi. Hailé Selassié, il Ras Tafari (era il suo nome) era sbarcato nel ‘66 a Kingston da Imperatore d’Etiopia, promettendo a tutti il ritorno. Lo consideravano il Messia, la reincarnazione di Cristo. Nel brano “War”, potente come un anatema, Marley utilizzò nel testo il discorso che Selassié aveva pronunciato tre anni prima all’Onu: un vibrante pronunciamento contro lo spettro della guerra atomica e ogni forma di sopraffazione razziale. Eppure Bob, seguace e mentore del rastafarianesimo, visse sulla propria pelle la violenza che prosperava in Giamaica: il 3 dicembre 1976, quando era già una star intercontinentale del reggae, fu centrato da due colpi mentre era in casa. Lo salvò l’intervento del manager, che restò gravemente ferito, così come sua moglie Rita. Due giorni dopo, malgrado lo choc, Marley partecipò al concerto “Smile Jamaica”, un’iniziativa di pacificazione tra le fazioni in lotta per il controllo dell’isola, “sponsorizzate” da Cia e Kgb.
Londra, poi il ritorno. E Milano
Ma le minacce costrinsero Bob a rifugiarsi a Londra, dove continuò a produrre capolavori discografici come “Exodus” che seguiva il successo degli album precedenti (su tutti, la pietra miliare “Rastaman vibration”). Tornò a Kingston per non mancare, nel ‘79, alla kermesse “One Love Peace Concert” dove fece salire sul palco i due leader politici rivali, Michael Manley ed Edward Seaga. Che, mentre Marley invocava Jah, l’Onnipotente, si diedero la mano facendo sperare in un superamento non solo simbolico della guerra civile strisciante in territorio giamaicano. Il 27 giugno 1980, quasi un anno prima della scomparsa, Bob Marley & The Wailers incantarono centomila persone a Milano, con il climax nella commovente, profetica ballata “Redemption Song”. La Storia, anche quella sera, avrebbe mostrato il suo lato più perfido: a San Siro il reggae faceva sognare un mondo riconciliato; nelle acque di Ustica, un DC9 dell’Itavia si inabissava con il suo carico di vittime innocenti. Un mistero che si originava nello stesso istante in cui Marley, mille chilometri più a Nord, entrava in scena.